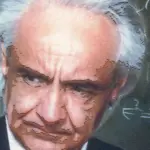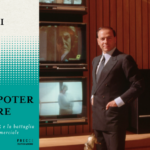Il Sud, le accise e la casa: come aggravare il gap di chi sta peggio
C’ è un punto di fondo, che ancora non è stato toccato nel convulso dibattito sull’aumento del prelievo fiscale italiano. E’ un punto che riguarda il nodo forse più di fondo della decrescita italiana, e del freno a recuperare il gap accumulato. Eppure, nessuno ci ha fatto caso, o almeno così mi sembra. Il che la dice lunga, su quanto l’attenzione pubblica sia lontana dal dramma del dualismo italiano: il dramma del Sud, che perde in questi anni anni molto più del Nord in termini di produttività, reddito disponibile, occupati.
Non amo le geremiadi di circostanza sul meridionalismo tradito. IL Mezzogiorno ha le sue colpe gravi, non è figlio di una spoliazione arcigna operata da rapaci nordisti. Per decenni, nella lunghissima stagione dell’intervento straordinario, decine di punti di Pil di risorse pubbliche sono state convogliate al Sud. Ma in 152 anni di storia unitaria il gap resta e si aggrava, rispetto alla lezione dataci dalla Germania in 20 anni su recupero e rilancio della sua parte orientale, ex Ddr. Detto questo, resto basito dal fatto che nessuno noti come la politica fiscale seguita in questi ultimi anni bastoni il Mezzogiorno ancor più duramente del resto d’Italia. E’ il Sud, infatti, la parte d’Italia più colpita dalle due tenaglie più affilate della strategia fiscale che emerge dalla legge di stabilità e dai decreti successivi, con cui il governo Letta sta tentando di rimediarne, dopo tanti mesi di preparativi e asgiustamenti, i guai.
Quali sono, le due tenaglie? Quelle alle quali la strategia fiscale di Letta e Saccomanni hanno affidato il più della messa in sicurezza dei conti 2014 e degli anni a venire, in mancanza dei tagli di spesa per i quali tutti continuano a citare la salvifica spending review di Cottarelli. Che però ha il difetto di non essere cifrata in termini precisi nella legge di stabilità, visto che i politici di ogni partito preferiscono sui tagli di spesa affidarsi a un tecnico esterno, pur di non pagare il prezzo dell’impopolarità. Le due tenaglie sono quelle del prelievo patrimoniale in particolare sugli immobili, e dell’aumento di accise ed imposte indirette.
Perché colpiscono più pesantemente il Mezzogiorno? Purtroppo è evidente. Nel primo caso, l’imposizione immobiliare, si tratta di entrate pubbliche definite prevalentemente su basi patrimoniali. Nel secondo caso, le imposte indirette dipendono dai consumi. In entrambi i casi, dunque, la base imponibile prescinde .- tranne che per parti infinitesime, come l’eventuale detrazione sulla componente Tasi della nuova IUC, che dovrà essere deliberata dai Comuni – dal reddito di coloro che ne vengono colpiti. Poiché il reddito procapite del Mezzogiorno è ormai in molti casi inferiore di un terzo o di quasi la metà rispetto a quello di alcune regioni del Nord, la morsa della scelta governativa rappresenterà un nuovo colpo asimmetrico a svantaggio del Mezzogiorno.
Per rinfrescare la memoria, se osserviamo le dichiarazioni 2012 dei redditi 2011 dei contribuenti italiani, rispetto a un reddito procapite di 23.210 euro della Lombardia, la Campania stava a 16.360 euro – quasi di un terzo inferiore – e la Calabria a 14.230 – inferiore del 40%. Su questa base di reddito disponibile tanto inferiore, sia i prelievi al consumo – accise e maggiorazione dell’IVA – sia quelli patrimoniali incidono in maniera regressiva, determinando cioè riduzioni del reddito disponibile tanto più gravi laddove, al Sud appunto, il reddito disponibile di base dopo questi anni di crisi tremenda già era tanto più basso.
Avrebbe dovuto pensarci, il governo, prima di decidere l’aumento delle accise sugli alcolici e sulle sigarette elettroniche, prima di alzare l’aliquota ordinaria IVA al 22% e dal 4 al 10% sui distributori automatici di alimentari e bevande, prima di elevare l’ammontare dell’imposta di registro e di quella suo conto-titoli di risparmio, o di diminuire la detrazione sulle polizze vita e infortuni. Ed è un bilancio negativo per il Sud aggravato dalla IUC, che somma la vecchia IMU residua, Tasi e Tari, con le sovraliquote per compensare i Comuni. Perché se andiamo a vedere il Rapporto Immobili 2012 elaborato dall’Agenzia del Territorio e dal Dipartimento delle Finanze, sui 24,6 milioni di italiani proprietari di almeno un’unità immobiliare, al Sud sia tra proprietari di prima che seconda casa i pensionati superano i lavoratori dipendenti, e nel loro caso il reddito disponibile nel Mezzogiorno è in media di poco superiore ai 12 mila euro l’anno, e in alcune regioni inferiore ai 10mila.
E’ ovvio che queste ragioni NON implichino affatto che non si debba mettere mano, in una situazione di conti pubblici tanto pregiudicata come quella italiana, anche a un riequilibrio nel quale la componente patrimoniale e quella indiretta delle entrate abbia un suo ruolo. Ma, appunto, deve trattarsi di un riequilibrio: cioè di un quadro generale di riduzione della pressione fiscale generale pluriennale in coerenza ai tagli di spesa, nel quale per generare crescita aggiuntiva le componenti patrimoniali e indirette vengano compensate da riduzioni delle aliquote marginali, medie e mediane del prelievo sui redditi delle persone fisiche e giuridiche. Se invece si procede per semplice sommatoria di aggravi su tutte le fonti di prelievo, quando il piede slitta sulla frizione delle imposte patrimoniale e indirette, allora si colpiscono di più i più poveri.
E’ un Paese smarrito e sulla via di perdersi, quello in cui si decide tutto questo a svantaggio di chi sta peggio. Quel che è peggio, poi: senza neanche rendersene conto.