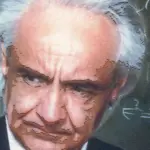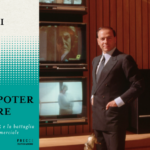Il Pd si rispacca sul “mito” art.18, e della produttività non si parla neanche stavolta
L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970 è un mito, per questo da decenni è diventato un tabù da non toccare. Perché i miti hanno forza evocativa, sono bandiere di valori, stendardi di visioni ideologiche. Per questo è così difficile mutarli. Non si piegano alla logica dei numeri. Rimbalzano sulla realtà dei fatti. Si misurano con metro delle utopie, non della realtà che per definizione non soddisfa l’idealista. Ecco perché da una parte è buona cosa, che Matteo Renzi abbia dato un forte impulso alla possibilità di modifcarlo, usando a sua volta termini “valoriali”, e proclamando “basta con l’apartheid dei diritti”. Dall’altra parte però bisogna saperlo: ora per una parte non trascurabile della sinistra e per i sindacati si ripropone lo stesso campo di battaglia sul quale hanno vinto e rivinto da 50 anni a questa parte, respingendo ogni volta chi voleva scalfire il mito. Il Pd ha gruppi parlamentari su cui Bersani, Damiano, Fassina, cobn la loro difesa del “mito” avranno gioco facile. E il rischio forte – ancora una volta – è che per unj compromesso dopo tanti aspri scontri NON si tocchi né si risolva il problema fondamentale.
Se guardiamo alla realtà, i termini della questione dovrebbero essere del tutto diversi. Per evitare l’ennesima “riforma al margine” delle regole sul lavoro – ogni governo italiano pasticcia con incentivi e disincentivi per questo o quel contratto, credendo di far bene e complicando solo la distorsione generale che su domanda e offerta di lavoro esercitano migliaia di pagine di norme – pochi numeri dovrebbero essere posti al centro. Se guardiamo alla popolazione tra i 15 e i 64 anni, a fine 2013 il tasso di occupazione italiano era al 49,9%, quello tedesco al 72,3%. Se depuriamo i dati dai cassintegrati e disoccupati “ufficiali” che risultano come lavoratori, “attivi” che cercano lavoro, e assumiamo come base l’intera popolazione nazionale, da noi lavora un italiano su tre, in Germania due tedeschi su tre. Questo è il problema numero uno: abbiamo un’enorme gap di occupabilità rispetto al quale rimuovere ostacoli, a cominciare da giovani, donne e over-55enni. Secondo problema, altrettanto grave: la produttività. Da noi i salari registrano da molti anni un andamento totalmente scollegato rispetto alla produttività: se guardiamo alla manifattura e considerando base 100 il 2000, la produttività oraria è salita solo verso quota 110 e i salari orari sono arrivati oltre quota 155, mentre nell’eurozona la produttività oraria è passata da 100 a 140 e i salari a 145. Una buona riforma del lavoro dunque deve unire l’identificazione e rimozione sia degli ostacoli all’occupabilità, sia quelli alla produttività.
Naturalmente, per gli idealisti dell’utopia questi numeri sono invece da respingere. Descrivono un mondo sbagliato perché vuole remunerare anche il capitale per produrre, mentre bisogna che le norme affermino un mondo dove non contano gli interessi, ma solo i valori. Se fate loro osservare che l’articolo 18 si applica oggi a una minoranza netta rispetto ai 22,4 milioni di lavoratori italiani ufficiali, visto che i dipendenti a tempo pieno e parziale sopra la soglia dei 15 per azienda sono circa 9,4 milioni, e dunque ha ragione Renzi a dire “basta apartheid” visto che ne sono esclusi i contratti a termine, i cocopro, gli autonomi, le partite IVA, ti rispondono che al contrario è un buon motivo per estendere l’articolo 18 a tutti i lavoratori: perché è questione di principio. E poco importa se l’estensione delle forme di lavoro meno tutelate per intere generazioni di più giovani è stata dovuta all’effetto -disincentivo rappresentato dall’elevato costo-fisso del rapporto di lavoro acceso “per sempre”, in aziende che oggi devono rispondere a una domanda che varia a settimana. Ti diranno che è colpa della globalizzazione, e a quel punto non c’è più confronto possibile. Visto che è proprio sull’export verso il mondo, che l’Italia deve puntare a breve per tornare alla crescita, mentre per rianimare la domanda interna serviranno tempi più lunghi.
Di conseguenza, la battaglia sarà dura. E il rischio è che ancora una volta si perda di vista l’obiettivo più importante. Con la delega emendata dal governo – e che in parlamento susciterà un duro contrasto anche nel Pd – si mira a un codice semplificato del lavoro che prevede un contratto d’inserimento triennale incentivato fiscalmente e a tutele crescenti, che prevede per i nuovi assunti in caso di licenziamento il superamento del reintegro giudiziale, che nella riforma Fornero convive ancora con la possibilità dell’indennizzo per i licenziamenti economici. Resterebbe solo l’indennizzo, proporzionato alla durata dell’impiego sinora svolto. Ma senza più distinzione di soglia dei 15 dipendenti, ed esteso anche agli ambiti di lavoro e contrattuali oggi esclusi.
Non è ancora chiaro se l’indennizzo resterebbe per i licenziamenti economici anche dopo i tre anni. Immagino di no, sarebbe sposare la posizione di Pietro Ichino in tutto e per tutto. Se si limita l’indennizzo per i licenziamenti economici a soli 30 mesi, come sembra di capire, in realtà si segmenterebbe ulteriormente l’apartheid italiana del lavoro. Ma il governo intende questo come “uno” dei pilastri, non “il” pilastro: perché si affianca a un nuovo strumento universale di sostegno al reddito per chi perde il lavoro, volto alla formazione e alla rioccupabilità tramite il nuovo “contratto di ricollocazione”, superando cioè in toto il sistema CIG e la sua illusione di difendere il lavoro “com’era e dov’era”; e alla rivisitazione profonda – speriamo coraggiosa – dei vecchi uffici provinciali del lavoro, creando un sistema di incrocio tra domanda e offerta aperto agli intermediari privati accreditati, e incentrato anch’esso su crediti di formazione per il reimpiego.
Da questo schema resta ancora totalmente fuori la produttività: occorre una svolta vera a favore dei contratti decentrati, dando loro la possibilità di prevalere sul contratto nazionale di categoria anche per la parte salariale. Lasciando alla contrattazione nazionale solo le tutele e i minimi salariali, cioè i “diritti”, ma scegliendo di trattare turni , orari e salari nelle aziende, compartecipando ai lavoratori premi retributivi sostanziosi quando le cose vanno bene, e decrementi a tutela dell’occupazione quando le cose vanno male. Lo ha scritto anche Tito Boeri ieri su Repubblica, e non è certo sospettabile di essere indifferente alla sinistra o sostenitore di Renzi.
E c’è anche un’altra insidia. Perché il nuovo contratto d’inserimento sarà interpretato dagli utopisti come una forma che deve sfociare comunque nell’assunzione a tempo indeterminato per tutti. Sbagliando due volte. Primo perché le imprese hanno bisogno anche dei contratti a tempo determinato, ed è stato saggio col decreto Poletti alleggerirne i vincoli. E secondo perché la strada maestra per l’inserimento al lavoro dovrebbe essere quella dell’apprendistato professionalizzante, affiancando scuole e università alle imprese sin dall’istruzione superiore, come avviene con enorme successo in Germania.
Siamo reduci dal fallimento degli incentivi al tempo indeterminato voluti da Letta e Giovannini, ed è in corso una colossale presa per i fondelli a 200 mila giovani che avevano creduto a Garanzia Giovani, e che in nove casi su dieci non hanno ottenuto sinora neanche un colloquio di orientamento. Ecco i nuovi frutti dell’utopismo calato dall’alto su troppe regole disincentivanti. Poiché è molto difficile aspettarsi dal governo un energico taglio delle imposte su imprese e lavoro, almeno ci si risparmino scioperi generali sull’articolo 18. Perché, con rispetto parlando, davvero non è il problema centrale dell’Italia, ma solo un mito che i numeri respingono. Gli stessi numeri che ci dicono che il problema vero è la produttività e la bassa partecipazione al lavoro dei giovani – per una scuola sbagliata – delle donne – per un welfare sbagliato – e degli anziani – per un sistema di riorientamento formazione-lavoro che manca.