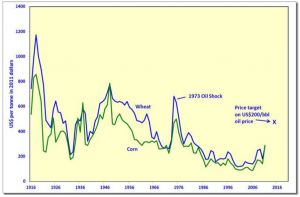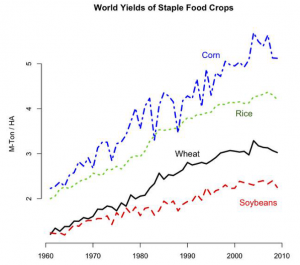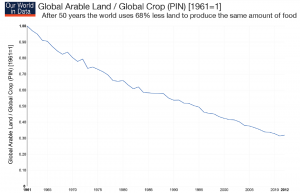Perché al liberale non piace l’8 x mille, e cosa vorrebbe invece
La Corte dei Conti anche quest’anno ha puntato il dito contro le molte anomalie dell’8 per mille, la modalità di finanziamento che dal 1985 è a disposizione dei contribuenti italiani per destinare una parte dell’IRPEF a sostegno delle confessioni religiose o dello Stato.
La Corte ha molte ragioni, in primis quella di suscitare molti pesanti interrogativi su un meccanismo che è asimmetrico e di fatto sfuggito di mano. Interrogativi ai quali però la politica è sorda, per non urtare la gerarchia della Chiesa cattolica italiana che del meccanismo – per come funziona – è la maggior beneficiaria, incassando da anni oltre un miliardo l’anno e cioè l’80 e più per cento del totale delle risorse assegnate.
Ma la Corte ha anche un limite evidente: le sue osservazioni valgono nel limite delle leggi vigenti. Che sono leggi sbagliate o quanto meno superate, almeno dal punto di vista liberale. Leggi che andrebbero ripensate in un’unica ottica: accomunare in una sola disciplina di agevolazione fiscale – neutrale, senza distinzioni dettate da discrezionalità politica – le libere scelte di donazione dei contribuenti a favore dei confessioni religiose, terzo settore e partiti. Spezzando le anomalie che in Italia separano 8 per mille riservato alle Chiese, 5 per mille alla sussidiarietà sociale e culturale, e 2 per mille alle forze politiche.
La politica non ne ha però alcuna intenzione. E sinora ha fatto orecchie da mercante anche alle osservazioni della Corte, che già l’anno scorso erano tal quali a quest’anno. La prima anomalia dell’8 per mille è che solo per la Chiesa cattolica derivi dal Nuovo Concordato tra Italia e Vaticano del 1984, che sostituì a firma Craxi quello fascista del 1929. Il leader socialista lo sottoscrisse pensando ai voti dei cattolici. Invece il tempo era maturo per una legge generale sulla libertà di culto in Italia, che equiparasse tutte le confessioni lasciandole libere di sottoscrivere intese con lo Stato. Al contrario, per l’8 per mille è competente una commissione paritetica Stato-CEI per quanto riguarda la Chiesa cattolica, mentre altre confessioni – valdesi, israeliti, luterani, chiesa avventista eccetera – hanno sottoscritto semplici intese. Ed è nella commissione mista Stato-CEI, che la politica italiana proprio non se la sente di affrontare le contraddizioni rilevate dalla Corte dei conti.
E’ verissimo che le risorse si sono triplicate in pochi anni, mentre per esempio quelle del 5 per mille sono fissate ogni anno dal MEF a seconda dei saldi di bilancio dello Stato, impedendo al terzo settore di poter pianificare pluriennalmente bilanci a sostegno dei malati, del patrimonio culturale e della ricerca. E’ verissimo che il meccanismo della ripartizione di quote integrando coloro che non optano a favore di nulla finisce per premiare la Chiesa cattolica: un meccanismo che dovrebbe essere considerato incostituzionale, come sostengono alcune altre confessioni. E’ altrettanto vero che la legge che ha introdotto l’8 per mille nel 1985 comunque ne identificava tre aree di utilizzo esclusivo da parte delle confessioni, mentre nel rendiconto generalissimo annuale redatto dalla CEI si capisce che gli scopi a cui sono volti i fondi sono anche altri. Ed è ancora vero che lo Stato, per parte sua, si è impadronito per altri fini di spesa corrente del più delle risorse annuali che i contribuenti gli riservavano per interventi che dovrebbero essere anch’essi esclusivamente sociali. Come è vero che non si è adoperato per smascherare e punire, in numerosi CAF che redigono le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, i falsi comprovati nell’attribuzione alla Chiesa cattolica di molte dichiarazioni inoptate.
Se lo Stato non si dà da fare con campagne di promozione pubblica per la scelta a proprio favore, e se non raddrizza tutte queste storture evidenti dell’8 per mille, è per non irritare la CEI. Ragione in più, allora, per evitare interventi solo mirati alle gerarchie cattoliche, superando una volta per tutte il regime concordatario e approvando una sola legge generale sulla libertà religiosa (e sui relativi doveri essenziali delle confessioni). Un ordinamento davvero liberale non dovrebbe conoscere distinzioni nelle agevolazioni fiscali concesse ai diversi soggetti ai quali il cittadino contribuente può scegliere di donare: si tratti di religione, sussidiarietà sociale e culturale, o politica. Invece abbiamo un sistema che strapremia la Chiesa cattolica, e che ha introdotto a favore della donazione ai partiti sgravi fiscali multipli di quelli riservati a chi vuole finanziare di tasca propria le università, o i musei, o le misericordie che assistono anziani e malati. Un paese che conta a favore della confessione più forte anche e soprattutto chi non esprime alcuna scelta cioè la maggioranza, e che taglia invece le risorse da destinare a chi invece sceglie esplicitamente questa o quella onlus del terzo settore “civile”. Un paese, in sostanza, ipocrita: perché finge di rispettare la libera scelta di dono dei suoi cittadini, e in realtà la piega alle convenienze della politica.