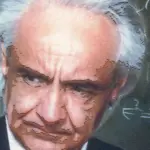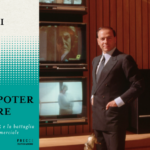Energia e clima: l’Ue conferma la sua leadership sulla via lastricata di buone intenzioni
La Commissione europea ha rivelato oggi il progetto per prolungare fino al 2030 la sua strategia industrial-ambiental-energetica: ridurre cioè le emissioni del 40% al di sotto dei livelli del 1990 e portare le fonti rinnovabili almeno a quota 27%.