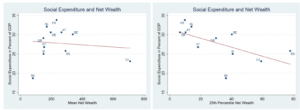Moltiplicatorao Keynesiao
Lo scorso 21 maggio Joao Ferreira, europarlamentare portoghese del Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea, presentò un’interrogazione scritta alla Commissione europea, che recitava più o meno così:
Aumentare il valore commerciale del pesce è un fattore chiave per risolvere il problema persistente del basso reddito nel settore della pesca.
In Portogallo, alcune delle specie pescate più di frequente non hanno nessun valore dal punto di vista commerciale, anche se sono una preziosa fonte di nutrimento. In altri casi, il loro valore commerciale è talmente basso che il prezzo di vendita non copre nemmeno i costi necessari a pescarli. È così, ad esempio, per specie come i sugarelli e i sugarelli blu, tra gli altri.
L’ultima riforma della politica comune della pesca (PCP) non ha creato le condizioni necessarie per una soluzione a questo problema cronico. Al contrario, avendo indebolito i meccanismi di intervento sul mercato da parte dell’Unione Europea, la situazione sta peggiorando.
Pertanto, chiediamo alla Commissione di farci sapere quanto segue:
– Quali strumenti sono disponibili nell’ambito della PCP e altri programmi per sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti che potrebbe aumentare il valore aggiunto di specie che hanno nessun o un bassissimo valore commerciale?
– Quali strumenti potrebbero contribuire ad aumentare il valore commerciale di queste specie (ad esempio campagne tra i consumatori)?
Chi di voi non è al quindicesimo bicchiere di Porto starà pensando dall’inizio dell’interrogazione una sola cosa: perché continuano a perdere tempo pescando quei pesci che nessuno desidera acquistare? Sarebbe come se domani io mi mettessi a raccogliere fili d’erba al parco e, non riuscendo a venderli, mi rivolgessi al Parlamento europeo per chiedere come aumentare il valore dei fili d’erba. Ebbene: la Commissione ha trovato il tempo di rispondere.
Ma questo è nulla. Martedì, il Parlamento europeo ha approvato il budget dell’Ue per il 2016. Il voto finale è arrivato dopo una sessione di voto sugli emendamenti presentati dagli europarlamentari sul testo predisposto dalla Commissione. Avete capito bene: tra quegli emendamenti, ce n’era uno, a firma del nostro Ferreira, che chiedeva di stanziare due milioni di Euro per un progetto di ricerca su – letteralmente – “come aumentare il valore del pesce senza valore”. Risultato: il Parlamento europeo ha approvato l’emendamento.
Raccoglitori di fili d’erba, fatevi forza: se vi è andata male con la legge di Stabilità e il reddito di cittadinanza è ancora una prospettiva lontana, potere sempre sperare nel Parlamento europeo. Il dibattito su come aiutare i più bisognosi – se regalando loro il pesce o insegnando loro a pescare – ha da oggi un nuovo capitolo: facendo pescare loro pesce che non vuole nessuno, a spese dei contribuenti. Ah, l’austerity!
Twitter: @glmannheimer