Perché sulla Cassa Depositi e Prestiti Massimo Mucchetti non mi convince
Venerdì 12 settembre su quotidianoenergia.it ho scritto di Cassa Depositi e Prestiti, cercando di mettere in luce i rischi della presenza in Italia di un moloch finanziario-economico di questo tipo gestito dai Governi protempore, cioè dalle maggioranze partitiche. Per semplificare il mio pensiero mi sono rifatto al più recente esempio disponibile, quello dell’Iri dell’epoca dei “boiardi di Stato” impegnati a tenere in piedi imprese decotte a spese della collettività. “Si scrive Cdp si legge Iri.” era il titolo del mio commento.
La domenica seguente, 14 settembre, nella sua rubrica sul Corriere della Sera, Massimo Mucchetti ha espresso un punto di vista diametralmente opposto: “La cassa depositi non è l’Iri. Purtroppo.” il suo titolo. Ho una profonda stima e provo amicizia per Massimo Mucchetti, uno dei pochi che si capisce crede in ciò che scrive e lo fa senza guardare in faccia nessuno, ma proprio per questo sento il dovere di cercare di spiegare perché non sono d’accordo.
Il suo riferimento è, ovviamente, l’Iri del fondatore Beneduce, degli anni Trenta, “non certo quella degli anni Ottanta”. Io invece credo che gli “anni Ottanta” siano inevitabili, soprattutto in democrazia. La politica, quando sono previste elezioni, lavora sul breve periodo, è la sua natura, e il personale politico può cambiare con molta frequenza. La (sana) esigenza di consenso è incompatibile con una gestione diretta da parte dei partiti delle imprese in mano allo Stato. E’ inevitabile che sia così, ed è anche giusto che lo sia: in campagna elettorale si lotta per il potere, che vuol dire poi poter gestire tutto ciò che è nella sfera pubblica.
Beneduce e i successori, invece, avevano alle spalle una dittatura – nel solo loro specifico caso non intrusiva – e la protezione personale di Mussolini . Per assurdo hanno potuto lavorare con la libertà del vero capitano di impresa e sul lungo periodo. Poi avevano una forte missione, di quelle che alle volte fanno preferire la scorciatoia del monopolio e dell’intervento pubblico, come il risanamento delle imprese travolte dalla crisi finanziaria del 1929: l’Iri nasce per gestire delle urgenze.*
Passata l’emergenza, separate e risanate le banche e le imprese, perché restituirle al mercato? Tutto va così bene! Inevitabile tenerle. Ed ecco pronta una nuova missione: il consenso, che avvicina la corruzione (in senso tecnico) dello spirito imprenditoriale. Il consenso politico non è tra i compiti delle imprese, è dei partiti e a loro deve restare. Esemplare il caso dell’Enel, monopolio nazionalizzato che ha lavorato bene finché ha avuto la grande missione di elettrificare l’Italia, per poi sedersi su se stesso appena raggiunto l’obiettivo. Da allora il compito dell’Enel è stato gestire il consenso per la Democrazia Cristiana che lo controllava attraverso il Ministero dell’Industria.
In quel contesto cosa altro avevano da fare i manager delle imprese pubbliche se non pensare all’autoconservazione? Inevitabile l’arrivo della corruzione (in senso giuridico). Giorni fa si sono commemorati i 50 anni dalla scomparsa di Enrico Mattei, il geniale costruttore del monopolio pubblico Eni (tra l’altro di fatto, senza neanche bisogno di farsi dare una concessione) e della sua proiezione internazionale, che serviva a garantire gli approvvigionamenti italiani di petrolio e gas (che sarebbero comunque arrivati lo stesso, come è stato quando la guerra civile in Libia ha bloccato in poche ore il 25% delle nostre importazioni).
Come non dare atto a Mattei dei suoi successi, ma come non ricordare il suo parallelo rapporto quantomeno equivoco con la politica? “I partiti sono come i taxi, li prendo e li pago”, diceva pubblicamente. Quanto ha pesato tutto questo sulla moralità pubblica nazionale negli anni a seguire? Intanto le imprese private subivano la concorrenza “sleale” di quelle pubbliche che godevano della garanzia statale. Finita la grande corsa della ricostruzione, al primo rallentamento, i privati hanno bussato cassa, trovando grande disponibilità.
Per la verità su questo ho un dubbio, non sono sicuro che siano state per prime le imprese a chiedere i soldi o i partiti ad offrirli, per mettere anche loro sotto controllo, perché anch’esse utili alla costruzione del consenso. Senza pudore: pensiamo agli Agnelli parlamentari in partiti governativi o direttamente ministri che portavano in dote anche importanti quotidiani e squadre di calcio. Se dio vuole i tempi sono comunque cambiati: immaginiamo Marchionne candidato da amministratore delegato Fiat o quel che l’è alle prossime elezioni nel PD o nel PDL (è lo stesso, entrambi farebbero a cazzotti per averlo)!
Comunque inutile adesso chiedersi se è nato prima l’uovo o la gallina, fatto sta che questa commistione tra pubblico e privato sussidiato, santificata dalla complicità di sindacati eterodiretti dai partiti ha evirato il Paese. Unico sprazzo il Craxi della scala mobile. A seguire il trucco molto italiano della svalutazioni competitive della lira e l’aumento della spesa pubblica, vero enorme sussidio di disoccupazione e altro strumento di consenso.
Poi l’arrivo dell’euro mentre era al potere una classe politica che si è dimostrata assolutamente incapace di gestire questa enorme opportunità. La minore spesa per interessi è stata scialacquata come se fosse l’ennesima svalutazione, senza rendersi conto che questa volta sarebbe proprio stata l’ultima.
Torniamo all’Iri, che ha funzionato bene anche nel dopoguerra, ma pure qui perché aveva una missione forte: rimettere in piedi il sistema industriale distrutto dagli alleati a dai tedeschi. Si comprende quindi che in determinate ed eccezionali situazioni gli Stati, anche con tradizioni di mercato libero diverse dalle nostre, come gli Stati Uniti nel 2008 all’inizio della crisi, ritengano di dover intervenire direttamente finanziando o acquistando in tutto o in parte le imprese, salvo poi rivenderle immediatamente (anche ad italiani!) appena avviato il risanamento (o anche lasciarle fallire: come Lehman).
Però altra cultura, altra indole, altro senso dello Stato e dell’interesse collettivo, soprattutto altra percezione del rapporto tra politica e imprese e quindi capacità di fare e vendere bene. E’ chiaro che se si cedono le imprese con il retropensiero di fare dei favori a degli amici o di gestire le cose per avere comunque una influenza sul loro futuro si finisce per sbagliare. Come è stato con la creazione delle fondazioni bancarie e dei “nocciolini duri”. Se poi i Presidenti del Consiglio si prendono le cotte per i “capitani coraggiosi” si perde lucidità e si fanno i disastri (io la chiamo la “sindrome di Stoccolma della sinistra italiana”).
E in ogni caso, contrariamente all’Iri di Beneduce e degli anni a seguire, la Cdp non può fare salvataggi. E allora che ci sta a fare? Perché statalizzare o acquisire parti di aziende già sane? I bot indicizzati all’inflazione sono andati a ruba pochi giorni fa, le famiglie hanno ancora molto risparmio che vorrebbero investire con sicurezza. Le azioni delle società delle reti come Snam e Terna (e spero presto anche Enel Distribuzione), con ricavi garantiti dalle tariffe, possono rendere anche di più dei bot: le loro cessioni retail sono sempre state un successo, anche nel 2001, dopo l’11 settembre. Certo sono meglio dei buoni di Poste spa su cui tutto si regge. Perché sottrarre queste azioni al mercato dei piccoli investitori?
Il perché è semplice. Più queste imprese sono solide e “regolate” più hanno credito presso le banche e più dividendi possono garantire alla Cdp che li passa al Tesoro (controllato dai partiti di governo pro tempore) e alle Fondazioni bancarie (30% di Cdp). Queste ultime, in cambio di un ricchissimo rendimento, servono a far finta che Cdp sia una vera Spa, non semplicemente un Ente pubblico, e quindi possa stare fuori dal bilancio dello Stato. Difficile poi sostenere che i manager di Cdp siano indipendenti dall’azionista. Non esiste “l’indipendenza di un dipendente” dallo Stato suo datore di lavoro.
Infine la Cdp non sarebbe una Iri perché i governi, incluso questo di Monti, non hanno il coraggio o la voglia di farne uno strumento di politica industriale. Sono d’accordo, è vero. La nuova Cdp infatti è stata concepita dal tributarista Tremonti come strumento di politica finanziaria, non industriale. Un altro sostituto di imposta per meglio tosare gli italiani: una pompa di benzina più raffinata. E su questo sono andati dietro tutti: spiace dirlo anche Siniscalco, Padoa Schioppa e Monti; Grilli è lì da sempre e tutto ha condiviso.
La Cdp sottrae ricchezza ai cittadini, drena risorse destinate a realizzare infrastrutture (che servirebbero a farci pagare meno l’energia) e si comporta come una banca qualsiasi (stessi tassi) anche nella sua originaria attività di finanziatore degli investimenti delle Amministrazioni pubbliche. Sbaraccarla e privatizzare tutto, facendo fluire nuove forze fresche, qualunque lingua parlino, questa sì sarebbe politica industriale!
*A questo proposito bisognerebbe anche chiedersi quanto lo stesso successo dell’Iri di quegli anni non abbia contribuito ad ancorare la destra italiana, e non solo quella ex missina, su posizioni di dirigismo economico, contribuendo a ritardare l’affermarsi di una destra autenticamente liberale anche in economia (con le dovute eccezioni che però sono rimaste casi singoli).




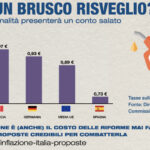












Ottima analisi.