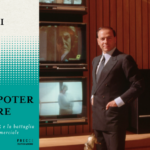Il grande equivoco del rilancio europeo
di Benito Arruñada
L’Europa inizia finalmente a parlare di sopravvivenza. Avendo preso atto della minaccia russa e della propria crescente irrilevanza politica ed economica, proliferano i rimedi che fanno appello alla competitività, all’innovazione e al mercato interno nella speranza di recuperare posizioni sulla scena internazionale.
I due esempi più noti sono i rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta. Pur essendo molto diversi, condividono una caratteristica cruciale: la presenza di un elemento magico nella misura in cui si presentano come compatibili con l’attuale struttura sociale ed economica. Persistono così sulla scia delle grandi iniziative europee dei decenni precedenti, dall’allargamento dell’Unione alla creazione della moneta unica. Sono quindi molto conservatori, perché promettono grandi benefici con costi minimi, senza alterare i diritti acquisiti né sostenere costi politici rilevanti. Il fatto che, nonostante ciò, vengano raccontati come audaci e innovativi, dà un’idea della distanza che dobbiamo ancora percorrere per iniziare ad accettare la realtà della nostra situazione.
Entrambi evitano la domanda che eludiamo da decenni: quanto dell’attuale benessere europeo è compatibile con una maggiore concorrenza, un rischio maggiore e maggiori esigenze strategiche? Qualunque sia il valore dello Stato sociale e dell’economia sociale di mercato, dobbiamo chiederci se un sistema progettato per attenuare ogni tipo di perdita possa essere sostenibile in un contesto che richiede l’accettazione di fallimenti personali, fallimenti aziendali, riassegnazioni di risorse e conflitti distributivi visibili.
Né Draghi né i suoi imitatori affrontano questa questione. Presentano l’innovazione come una cura indolore: più crescita e produttività, più risorse per la difesa e l’ambiente, il tutto senza intaccare i diritti acquisiti né ammettere l’esistenza di costi sociali. Vista in questo modo, la promessa è allettante perché evita il conflitto ed è politicamente digeribile. Permette di parlare di cambiamento senza discutere di sacrifici né indicare i perdenti.
Ma l’innovazione autentica non è un processo ordinato. Implica una distruzione creativa: ingresso e uscita di imprese, fallimenti, perdita di redditi consolidati, riassegnazione di capitale e lavoro, aumento dell’incertezza. Richiede di accettare che alcuni vincono e altri perdono: lo Stato non può attutire tutte le cadute senza finire per soffocare il processo innovativo. Presentare l’innovazione nascondendo gli attriti che provoca ne falsifica la natura. Ancora di più quando si propone di promuoverla massicciamente con fondi pubblici, come se la disruption potesse essere pianificata e sovvenzionata. Se non è disruptive, non trasforma; e se lo è, genera costi che qualcuno deve sostenere. Peggio ancora, quando l’innovazione passa attraverso il filtro delle commissioni pubbliche, si finisce per premiare l’influenza politica, non l’assunzione di rischi.
Qualcosa di simile accade con il mercato interno, il cui completamento è sostenuto da Letta. Svilupparlo significa intensificare la concorrenza e questo comporta accettare la scomparsa delle imprese meno efficienti, che tutti si sottopongano alla disciplina dei prezzi e dei salari e che aumenti l’esposizione alla competizione dall’estero.
Sarebbe una buona notizia per i consumatori e la produttività, ma non per coloro che vivono grazie all’esistenza di barriere, eccezioni o regolamenti su misura. Anche in questo caso ci sono vincitori e vinti. Fingere il contrario è un altro modo per nascondere la realtà. Il mercato interno non può essere completato senza chiusure di imprese e riassegnazione delle risorse.
Il problema non è che queste proposte non possano generare cambiamenti. Hanno il potenziale per farlo, ma nascondendone i costi – o presentandole come processi a basso costo sociale – rischiano di diventare carta straccia. Tenderanno a essere rinviate e diluite, concretizzandosi in versioni incomplete e inefficaci: la concorrenza sarà attenuata, i fallimenti saranno evitati e le decisioni di mercato saranno sostituite da decisioni politiche a vantaggio di chi cerca rendite. Si finirà per innovare con sovvenzioni e ampliare il mercato interno con nuovi ostacoli e condizioni, abbondando nella retorica del cambiamento mentre se ne neutralizzano gli effetti più scomodi e se ne sottraggono i principali benefici. Basti pensare alla recente “riforma” delle direttive sulla sostenibilità, una mera «semplificazione» che mantiene in vigore la maggior parte del suo parassitismo basato sulla ricerca di rendite.
A questo proposito, è rivelatore il silenzio di queste proposte sul fisco. Il rapporto Draghi le menziona appena e, nel rapporto Letta, le tasse appaiono come un problema tecnico dato da una eccessiva frammentazione dei sistemi tributari che conviene attenuare, non come una delle decisioni politiche più fondamentali per definire il nostro modello produttivo. Entrambi i rapporti parlano di incentivi, investimenti e finanziamenti, ma raramente trattano la pressione fiscale effettiva e la struttura della spesa come vincoli. In sostanza, mirano a rinnovare l’Europa mantenendo il timone sociale nelle mani degli stessi Stati che l’hanno messa in ginocchio. Si promette competitività senza discutere di cunei fiscali; si invoca l’innovazione senza chiedersi chi paga gli incentivi; si parla di risorse come se la loro scarsità e assegnazione fossero questioni tecniche e non politiche.
Alla mancanza di denaro si risponde con il credito. E quando alcuni paesi non hanno più margine di bilancio, invece di tagliare le spese si propone di mutualizzare il debito affinché possano continuare a spendere. Il fatto che queste soluzioni siano presentate come indolori la dice lunga sul tipo di decisione che si vuole evitare.
Questo pregiudizio non è casuale. Risponde a una cultura politica che ha imparato a rifiutare le perdite visibili e a esigere sempre protezione. In società di questo tipo, la concorrenza è tollerata solo finché non fa chiudere le imprese; l’innovazione è celebrata solo finché non distrugge i redditi; e la riforma è accettata solo se non altera i diritti acquisiti. Con queste preferenze, il silenzio sul fisco non è una dimenticanza, ma una condizione necessaria: consente di promettere risorse senza coperture esplicite e sposta le decisioni verso il debito, i sussidi e le eccezioni.
Con questo background culturale, qualsiasi tentativo di cambiamento finisce per trasformarsi in una gestione del rinvio: cioè nell’amministrazione ordinata di un declino che si preferisce non nominare. Questo rinvio lascia tracce evidenti: più debito comune, più eccezioni, più sussidi e meno concorrenza. L’innovazione funziona quando può fallire; il mercato interno funziona quando smette di proteggere; e la politica funziona quando valuta i costi invece di nasconderli. Senza l’onestà di aprire questi costi al dibattito pubblico, l’Europa non si riforma: si limita ad amministrarsi, e i risultati di tale amministrazione sono sotto gli occhi di tutti.
articolo pubblicato originariamente su The Objective il 21 dicembre 2025, https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2025-12-21/dieta-blanda-europa-articulo-arrunada