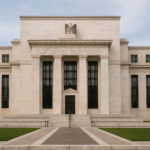Vie libere: la libertà e il movimento
Pubblico qui una versione estesa dell’inedita prefazione alla nuova edizione, in collaborazione con Autostrade per l’Italia, che Liberilibri manderà in libreria a fine novembre, del mio volume Vie libere. Topografia di anime in una città immaginaria, uscito originariamente nel 2019 presso il medesimo editore. Paolo Luca Bernardini
Sono felice che a distanza di alcuni anni dalla sua prima pubblicazione, Vie libere torni in nuova veste all’attenzione editoriale e a quella del mercato, e del pubblico sia degli interessati, sia degli studiosi. Sono dunque parimenti lieto di aggiungere una nuova prefazione a questa rinnovata edizione, che contribuisca viepiù a chiarire le intenzioni, gli auspici, i sogni e le riflessioni che vi sono dietro: dietro al libro, e al mio pensiero. E che vorrei davvero che almeno in parte (ma perché no, anche in toto) fossero trasmesse ai suoi nuovi lettori e venissero da loro recepite. Sono lietissimo, infine, che questo avvenga nel quadro di un’iniziativa di “Autostrade per l’Italia”, di cui sono da mezzo secolo affezionato cliente, tra l’altro. Come milioni di altri.
Per cui, qui e ora, vorrei trasmettere alcune riflessioni sul concetto di “via”, che è al contempo “viaggio” e “dimora”, in una bellissima ambivalenza teoretica, in una duplice dimensione, perfino, oserei dire, ontologica.
Vi è, per intanto, già qualcosa di straordinario nel concetto stesso di “strada”, o “via”, o “cammino”, “iter” e “itinerario”, insomma in tutta quella famiglia semantica che indica un percorso. Proviamo, per rimanere nella metafora linguistica, a percorrerne, per l’appunto, qualche confine concettuale.
La “via” è un luogo ove si risiede – fisicamente, legalmente – ed è dunque legata alla stabilità, alla permanenza per eccellenza. Ma la “via” è anche qualcosa che si percorre, senza risiederci, anzi, quante vie abbiamo percorso nella nostra vita senza sapere neppure il loro nome, la loro lunghezza, senza conoscere nessuno degli abitanti che in esse dimorano, dei negozi che le punteggiano, delle storie, leggendarie, o solo locali, ad esse legate. Questo rende affascinante il percorso, anche solo concettuale, nell’universo della “strada”, che è al contempo luogo per eccellenza di stabilità e permanenza, e situazione perfetta di trasformazione e mobilità. Vi sono poi, in questo universo così composito, realtà estreme, strade che non portano a nulla, strade solo per residenti, ad accesso limitato, e poi invece, all’opposto estremo concettuale, e reale, autostrade – luoghi per eccellenza di progresso, legate al progredire di ogni civiltà, che misura il proprio livello di maturità proprio dalla consistenza, resistenza, varietà della propria rete stradale e autostradale, come l’Impero romano e quello cinese – ove non si risiede, ma semplicemente si transita, a velocità infinitamente superiore rispetto a quella del viandante, del passante, dell’abitante di una romita località che magari in bicicletto o a piedi si reca alla propria abitazione, probabilmente per sentieri percorribili proprio solo a piedi, o con piccoli mezzi.
L’essere umano vive nella permanente dialettica tra stabilità e movimento, tra necessità di stanziarsi, e delimitare una proprietà, e desiderio (o necessità vera e propria) di proiettarsi nel vasto mondo, percorrere strade che non sono di sua proprietà (né di suo possesso concettuale, di sua conoscenza), affidarsi dunque all’alterità, per poi di nuovo crearsi il proprio spazio “recintato”, — la propria “enclosure” — e qui siamo di nuovo perfettamente nel territorio concettuale del pensiero libertario – ovvero: fermarsi.
Nella storia del liberalismo la libertà di movimento ha assunto, progressivamente, uno statuto essenziale tra le libertà, ovvero i diritti, fondamentali. Essa si associa ai primi tre: proprietà (anche di se stessi, del proprio corpo), libertà, e felicità, ma anche alla vita. Togliere la libertà di movimento significa imprigionare. Nella storia tale privazione, generalmente favorita da regimi totalitari, ma non solo da essi, ha assunto infiniti aspetti, forme, varietà. Le costituzioni davvero liberali assicurano la libertà di movimento insieme a quella d’associazione: e muoversi e associarsi sono in fondo concettualmente affini, l’associazione tra esseri umani presuppone il movimento. E viceversa. Tuttora difficile muoversi quando si viva in regimi estremi, dittatoriali. Emigrare, ad esempio. Ma è singolare che i tanti regimi totalitari che permangono al mondo – e che spesso fanno di tutto per impedire l’emigrazione dei loro cittadini, perché non solo perderebbero servi a basso costo, ma vedrebbero diffusa ancor più l’onta che grava su di loro, tramite la forza della testimonianza diretta – siano anche quei regimi ove non solo si ostacola la mobilità verso l’esterno, ma ove lo stesso sistema di mobilità interna è difficile, precario, spesso arretrato. E dove il sistema stradale, e quello autostradale (quando esista, quest’ultimo) sono in condizioni davvero provvisorie. Il dittatore non ama che il proprio schiavo si muova neppure all’interno di un territorio limitato, neppure all’interno dello Stato stesso di cui è cittadino.
Movimento, libertà. Un’equazione terribilmente semplice.
Quel che è vero nel regno naturale, soggetto a migrazioni regolari, massicce, essenziali per l’equilibro della natura, è vero anche per quel che riguarda gli esseri umani. Per questo il presente libro, che delinea un “paesello liberale” (definirla città, visto la smilza toponomastica, parmi davvero eccessivo) ove ogni via, largo, salita, è legata ad un personaggio che fu importante (che questo gli sia stato riconosciuto, o meno, dalla Storia), nel proprio contesto, e in generale, e che direttamente o indirettamente rappresentò il pensiero liberale (liberale-classico, o libertario), è anche un invito a riflettere sulla dialettica immanente tra movimento e stanzialità presente nel concetto stesso di “via”. Abbiamo or ora accennato a questo.
D’altra parte, anche solo una breve escursione nella nozione di “via” in ambito filosofico – a prescindere dalla declinazione in senso liberale della filosofia stessa, ovvero, a prescindere dal mio personale orientamento di pensiero – mostra bene la sua importanza, se non centralità, anche e proprio nei concetti-chiave stessi della filosofia occidentale: pensiamo a “metodo” (uno dei concetti principali, come è banale ricordare, del pensiero occidentale stesso): secondo il vocabolario Treccani: “dal gr. μέϑοδος, composto di μετα- («in direzione di», «in cerca di») e ὁδός («via», «cammino»). Da questa etimologia il termine trae il senso generale di ricerca o orientamento di ricerca, e il significato di insieme dei principi, delle regole e delle procedure per la conduzione di un’indagine, la soluzione di un problema o il raggiungimento di un obiettivo.” Ma un riferimento al cammino vi è anche in un lemma che utilizziamo tanto quanto “metodo” nel linguaggio comune, ovvero “problema”: sempre il Treccani: “dal lat. problema –ătis «questione proposta», gr. πρόβλημα -ατος, der. di προβάλλω «mettere avanti, proporre»”; ma anche, in accezione negativa, ovvero, “problematica”, il porsi-davanti è proprio dell’ostacolo, di quanto ostruisce il movimento (del pensiero, ma non solo): è caratteristica principale di quel che blocca la strada.
Molto vi sarebbe da dire, su questo, ma certamente, andremmo al di là dei naturali confini di una prefazione, che abbiamo già e di molto valicato, a bene vedere.
Le strade, i ponti, quel che congiunge, rappresentano un aspetto fondamentale dell’umanità. Lo storico della letteratura americano Thomas Harrison ha pubblicato nel 2021 un affascinante volume sul tema, Of Bridges: A Poetic and Philosophical Account (University of Chicago Press). Ma non per questo devono esser sempre costruiti ponti, e mai muri (affermazione che non so se Harrison sottoscriverebbe). Anche il muro delinea un’identità, segna il raggiungimento, magari provvisorio, della stanzialità: per l’individuo, per la famiglia, ovviamente, ma anche per una civiltà. La Storia umana ha bisogno sia di ponti, sia di muri. Il movimento crea un’identità, la stanzialità la consolida, e il muro delimita lo spazio di un’identità. Nella dialettica tra movimento e stanzialità si sviluppa il genere umano. Come riconoscono tutti i maggiori World Historian. Il ponte e il muro sono legati alla volontà delle collettività umane: vi possono essere ponti chiusi, e muri perfettamente valicabili.
Poi, vi sono numerosi altri motivi per riflettere sulle vie. Le strade hanno i loro nomi. Generalmente, le strade maggiori, le autostrade, tendono ad essere identificate tramite sigle – come la mia seconda casa, la A4 – ma la più lunga autostrada italiana, la A1, è nota come “Autosole” (nome assolutamente beneaugurale), ed è la spina dorsale d’Italia, il maggior asse meridiano della Penisola, un secondo Appennino, fatto dall’uomo, però. Invece le strade delle città e dei paesi hanno solo il loro nome, e riflettere su di esse, sulla toponomastica – come faccio io qui, in una toponomastica però tutta frutto della mia fantasia, e delle mie aspirazioni, e convinzioni liberali-classiche talora pronte a scivolare improvvisamente nel libertarismo puro – è esercizio salutare.
In fondo nelle strade e nei loro nomi si riflette l’identità dei luoghi, e sono occasionalmente quella di chi magari del tutto casualmente vi abita. Per me, aver vissuto dall’infanzia all’ultimo anno di università in una strada genovese legata alla Resistenza – intitolata ad Alessandro Rimassa, giovanissimo partigiano, dal bel volto severo e intelligente (come ce lo ricorda forse la sola foto rimasta di lui), abile disegnatore, fulminato da una sentinella tedesca vicino a Villa Gruber, nel quartiere di Castelletto, a soli diciotto anni, e ad un giorno dalla Liberazione, il 24 aprile 1945) – mi ha fatto capire, tra tante altre cose, l’anima e il destino della mia città natale, Genova. Nel bene, e nel male. Poi ho vissuto in tantissime altre strade, nel mondo, e ho sempre prestato attenzione al loro nome, al loro eponimo. A Londra vivevo in una “via” che non era una via, ma un crescente di luna: dedicato a San Marco. A Saint Mark’s Crescent – ove felicemente vissi in compagnia di Laura, a casa del mio professore di storia Edoardo Grendi, e avendo come vicino una rock star allegramente sul viale del tramonto, Adam Ant, tra le tante cose maturai, prima di approdarvi per sempre, il mio amore per Venezia. E capii come i luoghi ove dimorano gli uomini possono prendere tantissimi nomi, non sempre riproducibili nelle altre lingue. Il “Crescent” da noi non è che una “piazza”, non una “mezzaluna”.
Ora, per transitare quasi necessariamente al presente, scrivo queste righe da via San Mauro, a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, in un’afa agostana che pare senza rimedio, che fu sempre così dall’inizio dei tempi, e non per il supposto “cambiamento climatico” come ci fanno creder ora. San Mauro evoca il mondo benedettino delle origini. Quel mondo che ha qui vicino una testimonianza meravigliosa, anche se tarda, il Monastero di Praglia Seguace primo di San Benedetto, fu viaggiatore anche lui, si recò in Francia e vi edificò uno splendido monastero ora in rovina. Morì ad Angers nel 584. Viaggiatore a piedi, nell’uso dei tempi, è forse per un simpatico paradosso patrono (anche) degli storpi. Quando nel 1618, oltre mille anni dopo la sua morte, nacque la Congregazione Benedettina di Francia, in suo nome i monaci presero il nome di “maurini”. Pochi lo ricordano.
Queste righe – forse un pochino impressionistiche, ma spero buon viatico per un viaggio nel viaggio –, per mostrare come un libro che parli di “vie” – anche solo di un utopico quartierino, o villaggetto, o “città ideale” forgiata in un’onomastica di fantasia – e che parli di “anime”, mettendone insieme di così diverse tra di loro, così strambe se viste in un insieme, così “impossibili” da affratellarsi davvero, evochi in realtà – o meglio, possa evocare – dimensioni ulteriori e maggiori: il movimento, la stanzialità. Dimensioni reali, ma anche e soprattutto speculative.
Nello spirito poi delle “città ideali” rinascimentali, questo mio piccolo libro vuole evocare anche tali città stesse, e il fatto che nessuno ci impedisca di concepirle, indipendentemente dal fatto che poi vengano realizzate o meno. E soprattutto, esso vuole sollevare, nella sua propria modestia, una questione: che nomi daremmo alle strade e alle vie nella nostra, personalissima, “città ideale”? Qual nome sarà dato alle vie di Liberland quando finalmente quella microscopica isola sul Danubio tra Croazia e Serbia verrà edificata? Ecco uno stimolo, dunque, per il pensiero, un modo per rovesciare il giuoco del “Monopoli” per farcene uno personalissimo, magari ogni volta diverso. Ponendoci magari, complice l’afa estiva, domande forse surreali: “E se un giorno mi dedicassero una via, sarei contento?”; “E gli abitanti di quella via, si domanderebbero mai chi sono stato?”; “E chi per questa via casualmente passasse, saprebbe chi sono?”. Ogni stimolo per l’intelligenza in questi tempi dove quella artificiale cerca di sostituirsi troppo spesso a quella umana, anziché affiancarsi ad essa, è benvenuto. Sia benvenuto!
In ultimo, conviene riflettere sulla dimensione teologica del viaggio, fondamentale anche se apparentemente estranea allo spirito ed anche alla lettera di questo piccolo libro. Non solo del viaggio verso i mondi ulteriori. Anche e proprio del viaggio come dimensione del pensiero inevitabilmente legato alla meta ultima, come “itinerarium mentis in Deum”. Uno dei capolavori della mistica medievale, il libro di Bonaventura di Bagnoregio, si presenta già dall’inizio come una vera e propria cartina stradale. Di un viaggio certamente dello Spirito, innanzi tutto: ma favorito da uno precedente: in carne e ossa Bonaventura si ritira sul monte Verna, e lì, in solitudine e pace assoluta, può meditare su viaggi ulteriori. E compierli, anche solo nella mente.
Di nuovo, la dialettica, vitale, essenziale, tra movimento e stanzialità. Senza il, alla fine, forse non sarebbe possibile la seconda. O si realizzerebbe in forme estremamente primitive, indegne della natura, dell’indole, della missione dell’uomo, al di là di ogni metafisica.
P. L. B., Montegrotto Terme, agosto 2025